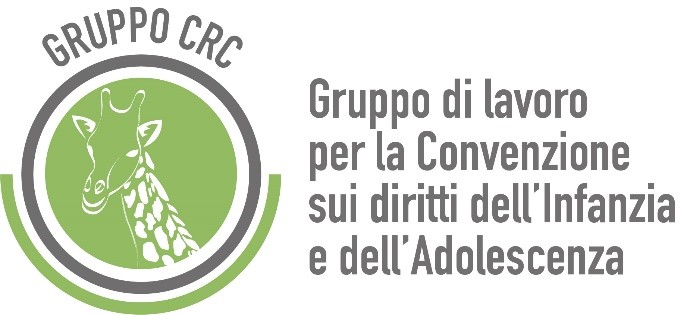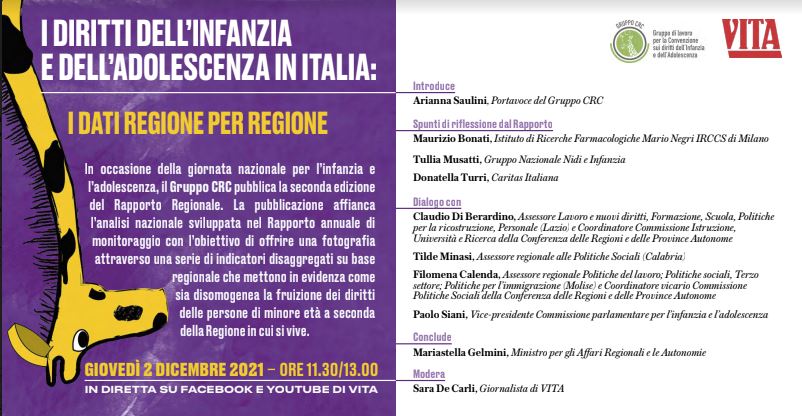da admin | Feb 12, 2025 | 5x1000, Rassegna stampa
L’Associazione “A Roma, Insieme – Leda Colombini ODV”, fondata nel 1991,
promuove campagne d’informazione, attività di formazione, di cultura e iniziative di
solidarietà sociale, con particolare attenzione alle persone detenute all’interno delle
carceri di Roma. I progetti sono resi possibili anche grazie alla partecipazione a bandi
finanziati da Enti Pubblici (Regione e Comune) e fondazioni private.
Dal 1994 si occupa delle donne detenute nella Casa Circondariale femminile di
Rebibbia e, in particolare, si prende cura dei bambini e delle bambine presenti presso
la Sezione Nido, che possono stare lì insieme alla loro mamme fino al compimento
del terzo anno di età.
Obiettivo principale dell’Associazione è che “nessun bambino varchi più la soglia
di un carcere”.
L’associazione ha sede in Roma, Via Sant’Angelo in Pescheria n. 35/A, all’interno di
locali di proprietà del Comune di Roma – Dipartimento Patrimonio e dal mese di
luglio 2024 abbiamo ripreso con il regolare pagamento del canone di affitto mensile,
essendo terminato un periodo di sospensione dovuto ad un credito da noi maturato
con il Dipartimento.
La Presidente, il Consiglio Direttivo e i soci/e volontari/e prestano la loro opera a
titolo completamente gratuito, fatta eccezione della persona addetta alla segreteria,
unica figura part-time a percepire uno stipendio. Alcuni dei progetti attivi
usufruiscono, a volte, della collaborazione esterna di professionisti il cui rapporto
economico rientra nell’ambito delle collaborazioni con lettere d’incarico per la
realizzazione del progetto.
Il contributo del 5×1000 relativo all’anno 2022-2021, accreditato sul c/c di questa
associazione in data 12/12/2023 (per importo pari a € 3.229,35) è stato utilizzato
esclusivamente per sostenere i costi di funzionamento dell’associazione e per
l’acquisto di prodotti utili al raggiungimento dello scopo sociale.
L’anno 2024, interessato dal contributo, è stato caratterizzato da una importante
riduzione della presenza di bambini presso la Sezione Nido della Casa Circondariale
di Rebibbia femm. dovuta alla possibilità (prevista per legge) che le mamme di
minori di anni 3 possano usufruire di misure alternative alla detenzione in carcere.
Partendo da questa premessa, anche quest’anno la nostra associazione, in continuità
con la collaborazione avviata con l’ASP Asilo Savoia grazie all’Accordo di Partenariato
sottoscritto in data 20 ottobre 2021, ha visto alcune/i volontari/e impegnate/i nel
supporto ai nuclei familiari mamma-bambino/a presenti presso la Casa Famiglia
Protetta di Leda. Le/i bimbe/i, in particolare sono stati/e sostenute/i nella
frequentazione di un corso di nuoto presso una piscina in prossimità della Casa
Famiglia di Leda. Nella stagione estiva (da fine giugno ai primi di settembre), grazie
alla rinnovata disponibilità ad ospitare i/le minori presso la Tenuta del Presidente di
Castel Porziano, tutti i sabati le/i piccole/i, accompagnate/i dalle nostre volontarie,
hanno potuto godere di un’intera giornata al mare. Fondamentale, ai fini della
realizzazione di questa attività è stato l’accordo raggiunto con la Protezione Civile
Arvalia ODV che ha garantito l’utilizzo di un pulmino per il trasporto. La spesa è stata
in parte a carico della nostra associazione (per un totale di n. 5 uscite) e in parte a
carico dell’Asilo Savoia (n. 3 uscite) . Invece per le mamme, presenti presso la Casa
Famiglia di Leda e sottoposte a misura di detenzione domiciliare, è stato attivato un
corso di italiano.
Quanto alle altre attività all’interno delle carceri presenti nella città di Roma, sono
proseguiti i colloqui settimanali con le donne detenute presso la Casa Circondariale di
Rebibbia. Inoltre, presso una delle Sezioni in cui sono rinchiuse alcune delle donne
non accompagnate da minori, è stato attivato il progetto intitolato “La fuga del
corpo” (Al Punto 1 del Modello alla voce “Risorse Umane” ), consistente in un corso
di danze popolari che promuoveva un approccio informale di condivisione e fiducia,
allo scopo di favorire la relazione tra le donne grazie anche al riconoscimento del
proprio spazio e di quello dell’altra come precondizione per potersi esprimere.
All’interno della Sezione Nido, per diversi mesi e in maniera continuativa, è stato
presente un bimbo minore di anni 3. La nostra associazione, tramite le sue
volontarie, è stata impegnata (nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2024)
nell’accompagno del bimbo presso un asilo nido esterno all’istituto penitenziario e nel
rientro pomeridiano.
Come ogni anno non sono mancate la realizzazione di feste e la consegna dei regali
in occasione di compleanni dei bimbi/e (presenti sia nell’Istituto Penitenziario di
Rebibbia che presso la Casa Famiglia Protetta) né di “piccoli pensieri” in occasione
delle annuali festività né il sostegno, con beni di prima necessità, alle famiglie con
disagio economico e sociale.
Gran parte delle concrete testimonianze di vicinanza e solidarietà sono state rese
possibili grazie al contributo del 5X1000 ricevuto e alle donazioni di chi ci segue da
anni (soci/e – volontari/e – amici e amiche di “A Roma, Insieme – Leda Colombini
ODV”).
Il contributo del 5×1000 ricevuto nel mese di dicembre 2023 è stato, infatti,
prevalentemente investito nelle spese indicate in “Voci di spesa riconducibili al
raggiungimento dello scopo sociale” al Punto 5 del Modello e in quelle al Punto 2
“Costi di funzionamento” relativi alle utenze della nostra sede, notevolmente
incrementati dal generale rincaro delle spese.
Non sono state fatte erogazioni a favore di altri enti o accantonamenti dell’importo
percepito.
La presidente
Giovanna Longo
Relazione
Rendiconto
da admin | Feb 12, 2025 | 5x1000, Rassegna stampa
Roma, 22 ottobre 2022
L’Associazione “A Roma, Insieme – Leda Colombini ODV”, fondata nel 1991,
promuove campagne d’informazione, attività di formazione, di cultura e iniziative di
solidarietà sociale, con particolare attenzione alle persone detenute all’interno delle
carceri di Roma. I progetti sono resi possibili anche grazie alla partecipazione a bandi
finanziati da Enti Pubblici (Regione e Comune) e fondazioni private.
Dal 1994 si occupa delle donne detenute nella Casa Circondariale femminile di
Rebibbia. In particolare si prende cura dei bambini della Sezione Nido che lì vivono,
fino al compimento del terzo anno di età con le loro mamme.
Obiettivo dell’Associazione è che nessun bambino varchi più la soglia di un
carcere.
L’associazione ha sede in Roma, Via Sant’Angelo in Pescheria n. 35/A, all’interno di
locali di proprietà del Comune di Roma – Dipartimento Patrimonio e, ad oggi, siamo
in compensazione della quota affitto in quanto creditori di una somma versata
anticipatamente.
La Presidente, il Consiglio Direttivo e i soci volontari prestano la loro opera a titolo
completamente gratuito, fatta eccezione della persona addetta alla segreteria, unica
figura part-time a percepire uno stipendio. Alcuni dei progetti attivi usufruiscono, a
volte, della collaborazione esterna di professionisti il cui rapporto economico rientra
nell’ambito delle collaborazioni con lettere d’incarico per la realizzazione del
progetto.
Il contributo del 5×1000 relativo all’anno 2021-2020, accreditato sul c/c di questa
associazione in data 16/12/2022 (per importo pari a € 3.197,32) è stato utilizzato
esclusivamente per sostenere i costi di funzionamento dell’associazione e per
l’acquisto di prodotti utili al raggiungimento dello scopo sociale.
L’anno 2022-2023, interessato dal contributo, è stato caratterizzato da una
importante riduzione della presenza di bambini presso la Sezione Nido della Casa
Circondariale di Rebibbia femm. dovuta alla possibilità (prevista per legge) che le
mamme di minori di anni 3 possano usufruire di misure alternative alla detenzione in
carcere. Partendo da questa premessa, anche quest’anno la nostra associazione, in
continuità con la collaborazione avviata con l’ASP Asilo Savoia grazie all’Accordo di
Partneriato sottoscritto in data 20 ottobre 2021, ha svolto varie attività con i nuclei
mamma-bambino presenti presso la Casa Famiglia Protetta di Leda. Sono, infatti,
stati sostenuti corsi di formazione lavoro, sartoria, di lingua inglese per adulti e
bambini, danza e arti performative, ludico artistico per bimbi. Inoltre, durante tutta
la stagione estiva, grazie alla rinnovata disponibilità ad ospitare i minori presso la
Tenuta del Presidente di Castel Porziano, tutti i sabati i piccoli, accompagnati dai
nostri volontari e dal personale della Casa Famiglia di Leda, hanno potuto godere di
un’intera giornata al mare. Fondamentale, ai fini della realizzazione di questa
attività, è stata la convenzione stipulata (e purtroppo scaduta nel dicembre 2023)
con il Dipartimento della Politiche Sociali e Salute della Città di Roma che ci ha
garantito l’utilizzo di un pulmino.
Quanto alle altre attività all’interno delle carceri presenti nella città di Roma, sono
proseguiti i colloqui settimanali con le donne detenute presso la Casa Circondariale di
Rebibbia e attivato in una delle Sezioni, in cui sono rinchiuse le donne non
accompagnate da minori, un laboratorio intitolato “Un libro in mente” cioè un
progetto di lettura condivisa seguita da una discussione mediata e guidata sulle
libere associazioni che la lettura aveva suscitato. Inoltre nel mese di novembre,
essendo presenti alcuni bimbi nella Sezione Nido, è stato avviato un laboratorio di
manipolazione e disegno a loro dedicato.
Nella casa Circondariale di Regina Coeli, in continuità con i laboratori già avviati negli
scorsi anni e grazie all’erogazione liberale del Fondo di Beneficenza Intesa Sanpaolo,
abbiamo attivato il progetto “Proiezioni d’arte in carcere”.
A tutto quanto sopra aggiungiamo che, anche quest’anno, non sono mancate la
realizzazione di feste e regali in occasione di compleanni dei bimbi oltre a “piccoli
pensieri” in occasione delle annuali festività. Queste testimonianze di vicinanza e
solidarietà sono state possibili grazie alle donazioni di chi ci segue da anni (soci/e –
volontari/e – amici e amiche di “A Roma, Insieme – Leda Colombini ODV”) oltre che
ad una parte del contributo del 5×1000 ricevuto.
Le attività che questo anno sono state realizzate negli istituti penitenziari, ad
esclusione di “Proiezione d’arte in carcere” e quelle presso la Casa di Leda con il
sostegno economico di Asilo Savoia, sono state portate avanti a titolo assolutamente
gratuito. Il contributo del 5×1000, quindi, è stato prevalentemente investito nelle
spese indicate alla voce “Costi di Funzionamento” al Punto 2 del Modello, al fine di
sostenere le spese delle utenze della nostra sede, notevolmente incrementate dal
generale aumento dei costi delle forniture.
Non sono state fatte erogazioni a favore di altri enti o accantonamenti dell’importo
percepito.
Roma, 1° dicembre 2023
La Presidente
Giovanna Long
Relazione
Rendiconto
da admin | Nov 27, 2023 | Rassegna stampa
INFANZIA E ADOLESCENZA
L’allarme del Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia: “I diritti mancati di una generazione sospesa tra sogni e incertezze”
L’evento, dal titolo “I diritti mancati di una generazione sospesa tra sogni e incertezze”, si pone l’obiettivo di creare un momento di dialogo che coinvolgerà i differenti livelli di governance protagonisti delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza. Numerose le testimonianze “dal campo” raccontate dalla voce degli operatori delle associazioni facenti parte del Gruppo CRC che ogni giorno, da differenti contesti e territori, lavorano con e per i ragazzi e le ragazze.
Sarà questa anche l’occasione per presentare il 13° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della CRC in Italia – 13° Rapporto CRC, redatto nel corso di questi ultimi mesi dalle oltre 100 associazioni parte del Gruppo CRC e appena pubblicato. Il Rapporto fornisce come sempre una panoramica completa di tutti i diritti riconosciuti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC), raggruppandoli in 10 capitoli e 46 paragrafi. Dall’analisi proposta dal Rapporto emerge in modo inequivocabile l’importanza di fornire risposte adeguate uscendo dalla logica degli interventi per singoli “settori” e avviando un processo di ricomposizione in grado di promuovere il benessere complessivo delle persone di minore età che vivono nel nostro Paese.
La fotografia che ci troviamo ad osservare è quella che ritrae una quotidianità in cui le ragazze ed i ragazzi che vivono nel nostro Paese manifestano un malessere diffuso che si esprime in diversi modi, ma riguarda tutte le sfere dell’esistenza e coinvolge le diverse fasce d’età. Pesa la percezione di un futuro incerto: crisi economiche ricorrenti, crescenti disuguaglianze, pandemia, guerre. Nello stesso tempo resta viva in molti bambini e ragazzi, sia la consapevolezza delle sfide che il mondo attraversa, sia la volontà di impegnarsi personalmente e collettivamente per affrontarle. Su queste grandi risorse, di coscienza e di solidarietà, si può e si deve far leva per rendere bambini e ragazzi più protagonisti del loro presente e del loro futuro.
Il lungo isolamento generato dal COVID ha comportato il rarefarsi dei luoghi di incontro ed ha indotto molti giovani e giovanissimi a chiudersi in sé stessi, ricorrendo ad un eccessivo utilizzo dei media. Inoltre, in molte delle nostre città mancano anche punti di riferimento territoriali, luoghi aggregativi aperti, spazi gioco, contesti di socializzazione occasionali e liberi come piazze e cortili.
È quindi necessario e doveroso che gli adulti assumano responsabilità e riconoscano le mancanze dell’attuale sistema per avviare un ripensamento complessivo delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza. Avendo un orizzonte temporale di lungo periodo ed in maniera che ciò coinvolga tutta la comunità educante. Per fare questo è centrale ascoltare le ragazze e i ragazzi, promuoverne il protagonismo e tenere conto delle loro esigenze e della loro opinione per giungere alla piena attuazione dei loro diritti.
Il Gruppo CRC, facendo leva anche sul prossimo appuntamento con il Comitato ONU, intende portare l’attenzione delle istituzioni sulle criticità del nostro sistema, valorizzando i punti di forza che emergono anche delle molteplici esperienze condotte a livello territoriale, per innescare un cambiamento sistematico che veda tutti protagonisti nel farsi carico delle esigenze di una generazione sospesa tra sogni e incertezze.
Il 13° Rapporto CRC è disponibile su: https://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2023/11/RAPPORTO-CRC-2023.pdf
da admin | Giu 8, 2023 | 5x1000, Rassegna stampa
Roma, 22 ottobre 2022
L’Associazione “A Roma, Insieme – Leda Colombini ODV”, fondata nel 1991, promuove campagne d’informazione, attività di formazione, di cultura e iniziative di solidarietà sociale, con particolare attenzione alle persone detenute all’interno delle carceri di Roma. I progetti sono resi possibili anche grazie alla partecipazione a bandi finanziati da Enti Pubblici (Regione e Comune) e fondazioni private.
Dal 1994 si occupa dell’affettività in carcere con le donne detenute nella Casa Circondariale femminile di Rebibbia. In particolare si prende cura dei bambini della Sezione Nido che vivono fino al compimento del terzo anno di età con le loro mamme dietro alle sbarre.
Obiettivo dell’Associazione è che nessun bambino varchi più la soglia di un carcere.
L’associazione ha sede in Roma, Via Sant’Angelo in Pescheria n. 35/A, all’interno di locali di proprietà del Comune di Roma – Dipartimento Patrimonio e, ad oggi, siamo in compensazione della quota affitto in quanto creditori di una somma versata anticipatamente.
La Presidente, il Consiglio Direttivo e i soci volontari prestano la loro opera a titolo completamente gratuito, fatta eccezione della persona addetta alla segreteria, unica figura part-time a percepire uno stipendio. Alcuni dei progetti attivi usufruiscono, a volte, della collaborazione esterna di professionisti il cui rapporto economico rientra nell’ambito delle collaborazioni con lettere d’incarico per la realizzazione del progetto.
Il contributo del 5×1000 relativo all’anno 2020-2019, accreditato sul c/c di questa associazione in data 29/10/2021 (per importo pari a € 3.115,12) è stato utilizzato esclusivamente per sostenere i costi di funzionamento dell’associazione e per l’acquisto di prodotti utili al raggiungimento dello scopo sociale.
Anche l’anno 2021-2022, interessato dal contributo è stato, purtroppo, caratterizzato dalla importante riduzione delle attività all’interno delle carceri in cui l’associazione è impegnata (Rebibbia e Regina Coeli) causata dalla crisi sanitaria in corso e dalla conseguente chiusura, degli istituti penitenziari, all’ingresso di operatori esterni e non solo. Abbiamo partecipato al “Bando Ristori” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali erogatoci, però, a dicembre del 2022.
Ciò nonostante l’associazione ha continuato ad impegnarsi nel sostegno economico e di sostegno solidale con le persone maggiormente provate dalla crisi sanitaria: persone detenute e loro familiari.
Inoltre, in collaborazione con la Fondazione Asilo Savoia, con cui é stato sottoscritto un Accordo di Partneriato relativo alle attività di volontariato presso la Casa Famiglia Protetta di Leda, sono state svolte varie attività con i nuclei mamma-bambino lì ospitati. Le donne-madri si trovano presso quella struttura in misura alternativa alla detenzione in carcere.
Il contributo del 5×1000 è stato prevalentemente investito nelle spese indicate alla voce corrispondente al Punto 5 del Modello, perseguendo gli scopi sociali dell’associazione: quello di alleviare, anche solo con piccoli doni, la condizione delle donne e madri detenute insieme ai loro piccoli e di tutte le persone detenute negli istituti penitenziari per adulti presenti nella città di Roma.
Il restante importo del 5×1000 ricevuto è stato impiegato per le spese alla voce Punto 2 del Modello “Costi di Funzionamento” nelle quali rientrano le utenze e i servizi.
Non sono state fatte erogazioni a favore di altri enti o accantonamenti dell’importo percepito.
La presente relazione sarà consultabile qui di seguito.
La Presidente
Giovanna Long
Relazione
Rendiconto
da admin | Mar 22, 2023 | Rassegna stampa
L’infanzia non si incarcera!
Una lettera-appello per non bloccare la legge.
In seguito alla presentazione di emendamenti che fermano la proposta di legge in Commissione Giustizia della Camera, associazioni, garanti e singoli soggetti impegnati sul tema dei diritti in carcere chiedono di non tradire il lavoro svolto finora e di accelerare l’approvazione Un appello rivolto al Presidente e ai componenti della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati per ripristinare lo spirito originario della proposta di legge d’iniziativa dei Deputati Serracchiani, Costa, Di Biase, Casu, Furfaro. A.C. n. 103 e liberare finalmente i bambini detenuti nelle carceri a seguito delle mamme.
Ad inviarlo oggi Cittadinanza attiva e A Roma Insieme – Leda Colombini, con la sottoscrizione di altre 12 organizzazioni civiche e di volontariato attive sul tema dei diritti dei detenuti, nonché di 4 Garanti dei diritti delle persone private della libertà e del Presidente della Conferenza dei Garanti Territoriali. Attualmente la proposta di legge “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori” è ferma presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, per via della presentazione di una serie di proposte di emendamenti: una situazione – si legge nell’appello – “estremamente preoccupante, sia perché rischia di aprire una nuova fase di stallo sul provvedimento, sia perché gli emendamenti depositati depotenzierebbero l’intero impianto della proposta di legge, contraddicendone finalità e motivazioni.”
La proposta di legge, nata su iniziativa dell’ex onorevole Siani e che nella scorsa legislatura non aveva completato l’iter di approvazione a causa della caduta del Governo Draghi, si inserisce in un percorso di proficua e positiva collaborazione tra Parlamento ed organizzazioni della società civile, contrassegnato da una grande spinta e valenza civica che non ha mai avuto bandiere. Introduce misure efficaci e ragionevoli, rimuovendo anzitutto ostacoli e limiti – di natura economica e giuridica – presenti nella normativa vigente che continuano ad alimentare il fenomeno dell’incarcerazione dell’infanzia e a produrre nuovi ingressi di bambini in carcere al seguito delle madri.
Tra le più apprezzabili, le disposizioni rivolte a sostenere e promuovere il sistema delle case famiglia protette come modello alternativo alle soluzioni detentive di madri e bambini, comprese quelle della detenzione negli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM). Da qui l’appello delle organizzazioni e dei vari soggetti che chiedono ai parlamentari di non fermare questo percorso e di recuperare lo spirito originario affinché il testo completi quanto prima l’esame in Commissione Giustizia, senza modifiche che ne tradiscano l’intento o esulino dalla esplicita finalità: ossia che i bambini e le bambine possano vivere i loro primi anni di vita con le madri, siano esse in attesa di giudizio o in esecuzione penale, in un ambiente non detentivo.
Aderiscono all’iniziativa
da admin | Nov 24, 2021 | Rassegna stampa
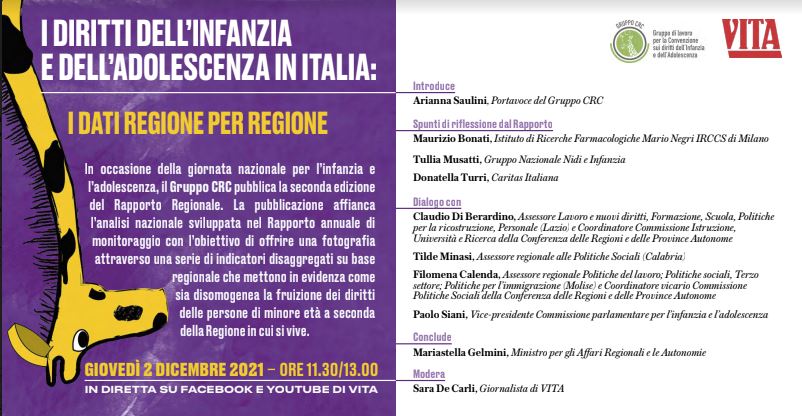
Il Gruppo CRC pubblica, in occasione della giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la seconda edizione del Rapporto “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia – I dati regione per regione 2021”, a distanza esatta di tre anni dalla prima. Il Rapporto sarà presentato nel corso di un evento on line promosso in collaborazione con Vita il prossimo 2 dicembre, ed a seguire sono stati programmati una serie di appuntamenti (in presenza e online) a livello regionale (si parte il 10 dicembre con Palermo e Trieste).
La pubblicazione affianca l’analisi nazionale sviluppata nel Rapporto annuale di monitoraggio con l’obiettivo di offrire una fotografia regionale attraverso una serie di indicatori, offrendo utili spunti per ulteriori approfondimenti. In particolare, sollecita le istituzioni pubbliche alla raccolta puntuale, sistematica e disaggregata di informazioni necessarie a programmare interventi efficaci e sostenibili per i bambini, le bambine, gli adolescenti e le loro famiglie.
Come recentemente evidenziato anche dal Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nelle proprie raccomandazioni all’Italia occorre “portare avanti misure urgenti per rispondere alle disuguaglianze regionali rispetto all’accesso al sistema sanitario, alla lotta alla povertà, alla garanzia di alloggi dignitosi, inclusa la prevenzione di sgomberi, allo sviluppo sostenibile e all’educazione in tutto il Paese”.
In Italia permangono ancora numerose e profonde diseguaglianze regionali nell’accesso e nella qualità dei servizi di salute, dei servizi educativi, e nell’incidenza della povertà, che vuol dire che le persone di minore età hanno differenti opportunità e diritti a seconda di dove nascono e crescono. Si tratta di una discriminazione su base regionale, che ha un forte impatto sulla vita dei bambini, e che rende indispensabile avviare una programmazione strategica in grado di investire con efficacia le risorse per l’infanzia e l’adolescenza, comprese quelle che arriveranno dal livello europeo, sia dal PNRR che dai fondi della prossima programmazione 2021 -2027. I tempi sono ormai maturi anche per colmare la carenza di dati riguardo l’infanzia e adolescenza, che caratterizza alcuni settori in modo particolare, e l’adozione della Garanzia europea per l’infanzia (Child Guarantee), che prevede tra l’altro “di aumentare la disponibilità, la portata e la pertinenza di dati comparabili a livello dell’Unione” relativamente alle persone di minore età, può essere l’occasione per compiere un passo in avanti anche nel nostro Paese.
Con questo lavoro le associazioni del Gruppo CRC intendono stimolare e contribuire ad un processo che porti ad una maggiore conoscenza e consapevolezza della condizioni dell’infanzia nei singoli territori, e conseguentemente superare le disparità che sono sempre più evidenti.
La pubblicazione è organizzata in schede regionali che offrono dati sintetici e comparabili relativi alle aree tematiche individuate. Partendo dai contenuti dei rapporti annuali di monitoraggio, sono stati individuati sette raggruppamenti tematici, due in più rispetto alla prima edizione. Per ognuno di essi è stato individuato un set di indicatori che, seppur limitato, anche in considerazione della difficoltà di reperire dati disaggregati per la fascia 0-17 anni a livello regionale, possa rappresentare la condizione dell’infanzia nei diversi territori per le specifiche aree tematiche.
Leggi il rapporto